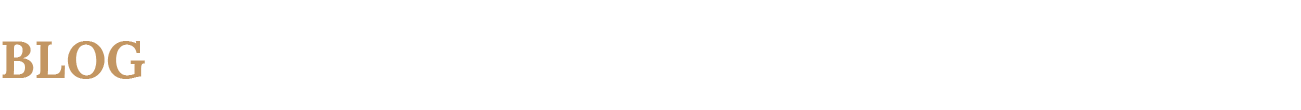
A questo mondo tutto ciò che ha un inizio, ha una fine. Anche in amore può non andare come si sperava. Così, si finisce per separarsi e dopo per divorziare. Con il divorzio si ha lo scioglimento del vincolo del matrimonio. Se celebrato con il rito religioso, si definisce cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con il divorzio, le parti riacquistano lo stato libero, la moglie perde il cognome del marito. Viene anche meno il dovere di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione, di assistenza morale e materiale.
Seppur vengono meno la fedeltà, la coabitazione, l’assistenza morale e materiale, nei confronti dell’ex coniuge resta un dovere di solidarietà. Pertanto, quando l’ex coniuge è economicamente più debole, può essere stabilito in suo favore un assegno di mantenimento. Può essere richiesto sia dall’ex moglie che dall’ex marito (ne abbiamo parlato qui https://simplius.it/in-caso-di-separazione-il-marito-povero-ha-diritto-al-mantenimento).
È il pagamento periodico che l’ex coniuge è tenuto a dare- in forza di una sentenza o altro provvedimento- al coniuge meno abbiente dopo il divorzio.
Negli anni è stato un tema piuttosto dibattuto nei Tribunali italiani. In un primo momento la Cassazione (1) ha individuato il parametro nel “tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio”. Qualche anno dopo la Cassazione (2) ha affermato che il criterio di liquidazione dell’assegno di divorzio non può essere quello del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, il parametro da utilizzare è solo quello assistenziale, laddove l’ex coniuge non abbia mezzi adeguati per vivere.
In sostanza la quantificazione dell’assegno dipende dalla verifica delle condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato durante il rapporto matrimoniale, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio.
Ultimamente i giudici hanno valorizzato, nella quantificazione dell’importo, la funzione perequativa-compensativa dell’ assegno divorzile. In altre parole si fa riferimento al sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato, durante il matrimonio, a realistiche occasioni professionali-reddituali dovendo occuparsi delle esigenze della famiglia e dei figli, contribuendo, in tal modo, alla crescita patrimoniale comune.
Occorre precisare che il riconoscimento dell’assegno divorzile non deriva dallo squilibrio economico, o dal fatto che uno si sia dedicato alla cura dei figli. Questi costituiscono alcuni parametri per ottenerne il riconoscimento. Il richiedente deve provare in concreto le ragioni e le conseguenze derivanti dalla scelta di dedicarsi all’attività familiare (3).
L’ex moglie che si è dedicata all’attività domestica favorendo l’attività professionale del marito medico, difficilmente otterrà l’assegno divorzile se si limiterà a dire “solo” di aver svolto la casalinga durante il matrimonio, mentre il marito ha curato la carriera. Perché l’essersi dedicata alla cura della casa e dei figli non consente un automatismo valutativo che porta al riconoscimento di quella funzione compensantiva dell’assegno divorzile (4).
In sostanza bisogna dimostrare la radice causale della disparità, ossia le ragioni dello squilibrio economico conseguente al divorzio, il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali per aver consumato un ruolo di collaborazione alla crescita del patrimonio, attraverso la cura della famiglia e dei figli, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente.
Con il divorzio non si estingue il vincolo di solidarietà sorto con il matrimonio. L’assegno divorzile svolge una funzione assistenziale e compensativa in ragione della tutela del benessere economico che l’ex coniuge ha riposto nel matrimonio e che ha nutrito in modo proporzionato alla durata del rapporto. È a garanzia del riconoscimento del contributo apportato dal meno abbiente, anche con il lavoro casalingo, tenendo conto dei sacrifici e delle aspettative economiche e professionali in ragione dell’interesse familiare.
1. Cassazione civile, Sez. I, sent 15 maggio 201 n.11686
2. Cassazione 10 maggio 2017 n.11504
3. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n.18287/2018
4. Cassazione civile, sez.VI-I, 13 ottobre 2022 n.29920
5. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32644
